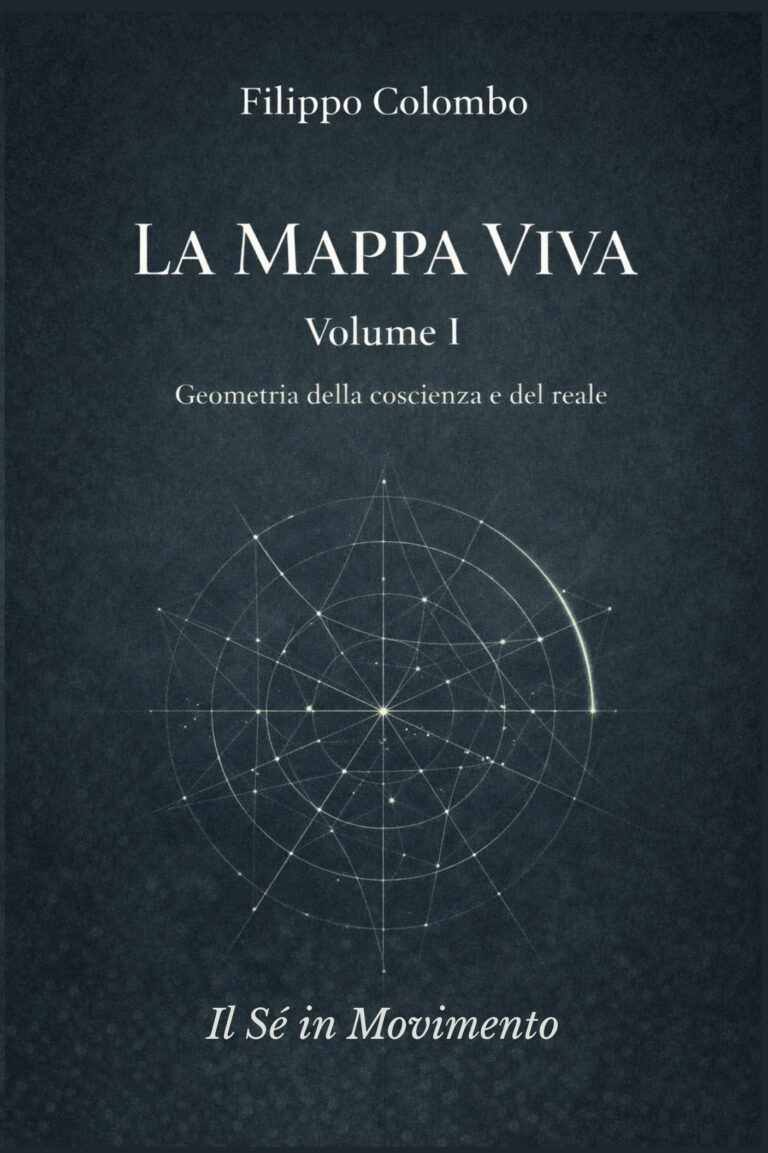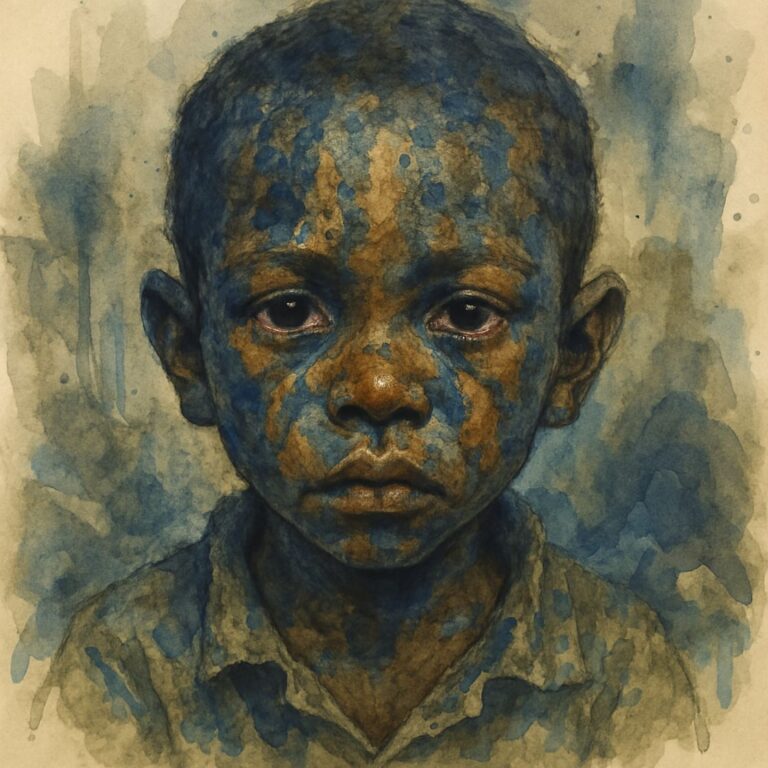“E tu, che lavoro fai?”
Domanda semplice, no? In realtà è un’arma a doppio taglio, usata nei brunch con sconosciuti e nei funerali emotivi di chi non sa più chi è. Perché oggi l’identità passa dalla professione, e se non hai un lavoro con un nome figo e un profilo LinkedIn attivo, rischi di sparire più del tuo CV tra le email degli HR.
Ma com’è successo che il lavoro – che un tempo era attività condivisa, gesto rituale, fare con le mani e con il senso – sia diventato una specie di religione tossica, che misura il tuo valore in ore, KPI e ansia?
Questo articolo è un viaggio senza badge aziendali tra passato, presente e futuri ancora non progettati. Ripercorreremo l’evoluzione del lavoro come specchio dell’essere umano, attraversando la lotta tra uomo economico e uomo sociale, tra specializzazione e versatilità, tra chi può scegliere il lavoro dei sogni e chi sogna solo di smettere di lavorare.
E alla fine ci chiederemo: la scuola e l’educazione, oggi, preparano a un futuro di libertà o solo a un presente di sopravvivenza?
Il problema non è solo il lavoro. È come l’abbiamo pensato, normalizzato e imposto. Ma anche questo, per fortuna, si può cambiare.

Le radici del lavoro: sopravvivere, servire, significare
Quando il lavoro non era un lavoro (ma un gesto, un ciclo, una danza)
C’è stato un tempo – lungo decine di migliaia di anni – in cui il concetto di “lavoro” semplicemente non esisteva. Esisteva il fare. Il vivere. Il procacciarsi il cibo, costruire un riparo, accudire i piccoli, seguire il ritmo del giorno e della stagione. Nessuno aggiornava il CV della tribù. Nessuno chiedeva a un raccoglitore nomade: “e tu cosa fai nella vita?”.
In quel contesto, ogni attività aveva un significato intrinseco: non era separata dalla vita, ma era la vita. Il “tempo libero” non esisteva, perché non c’era ancora la prigione concettuale del “tempo produttivo”.
Il gesto umano era intero, rituale, relazionale. Si faceva qualcosa insieme, per necessità, ma anche per connessione. Il lavoro – o quello che oggi chiamiamo così – era azione integrata: con la natura, con la comunità, con il proprio corpo.
Poi qualcuno ha inventato l’agricoltura. E da lì, niente è stato più come prima.
Il mestiere come gerarchia: nasce il lavoro come destino
Con la rivoluzione agricola, arriva la sedentarietà. La terra da coltivare, da possedere, da difendere. E con essa:
- la divisione dei ruoli,
- la proprietà privata,
- e – sorpresa – lo sfruttamento.
Nasce la distinzione tra chi comanda e chi lavora per.
Il lavoro diventa posizione sociale: servo, schiavo, contadino, artigiano.
Si lavora per altri, sotto altri, grazie ad altri.
E soprattutto: non si sceglie. Si nasce in una condizione e lì si resta.
Il lavoro diventa destino. E, nella maggior parte dei casi, una condanna.
I Greci liberi non lavoravano. Contemplavano. Il lavoro era per gli schiavi.
I Romani ricchi lo delegavano. I poveri lo subivano.
Solo con l’arrivo delle religioni monoteiste, e in particolare con il cristianesimo, il lavoro assume una nuova aura: diventa dovere morale, espiazione del peccato, via alla salvezza. L’etica protestante gli darà poi il colpo di grazia: lavorare duro è segno di elezione divina. E se soffri? Bene, ti stai purificando.
Benvenuti nell’era in cui il lavoro non è più solo funzione ma prova spirituale.
E l’ozio non è più madre di virtù, ma di colpa.
Dall’unità alla frattura: nasce il lavoratore
Nel passaggio dalla bottega al capannone, il gesto umano perde qualità e diventa quantità.
Con la rivoluzione industriale, il lavoratore diventa parte del meccanismo, non creatore.
- Prima: un calzolaio faceva una scarpa dall’inizio alla fine, con sapere e orgoglio.
- Dopo: premi un pedale e ripeti un movimento per otto ore. Se ti lamenti, c’è la coda fuori.
Nasce l’alienazione: l’essere umano si separa dal suo fare.
Il tempo diventa denaro.
Il corpo, strumento.
La mente, fastidio.
E così, il lavoro – che un tempo era connessione tra l’uomo e il mondo – diventa baratto tra energia e sopravvivenza.
La modernità e la mitologia del lavoro
Lavorare per essere: il mestiere come identità
Con l’avvento dell’età industriale, il lavoro smette di essere un destino imposto dalla nascita e diventa qualcosa di ancora più subdolo: una promessa di emancipazione.
“Se lavori sodo, puoi diventare qualcuno”.
Chi? Non si sa. Ma qualcuno, purché tu non sia nessuno.
La fabbrica prima, l’ufficio poi, diventano i nuovi templi dell’identità moderna.
Il tempo viene spezzettato in turni, orari, cartellini.
Il corpo si piega alle macchine, la mente agli obiettivi.
E nasce una nuova figura mitologica: il lavoratore realizzato.
Quello che ama quello che fa, che ci mette passione, che “non lavora un giorno della sua vita”.
Che magari è anche morto a 44 anni per una gastrite da riunioni, ma hey – l’importante è aver dato tutto.
Il lavoro, da strumento di sostentamento, si trasforma in metrica del valore personale.
Non sei più solo quello che fai. Sei quanto vali mentre lo fai.
Il posto fisso, l’ascensore sociale e l’illusione meritocratica
Nel secondo dopoguerra, il lavoro diventa sicurezza.
La fabbrica garantisce uno stipendio, la scuola promette un impiego, lo Stato ti vende la pensione.
È l’epoca d’oro del posto fisso: quel miraggio rassicurante che, per almeno due generazioni, è stato sinonimo di vita riuscita.
E insieme, nasce il mito della carriera. L’idea che se studi, ti impegni, ti sacrifichi abbastanza… verrai premiato.
Peccato che fosse una bugia a tempo determinato, buona solo per chi ha vissuto in quell’intervallo storico in cui l’economia cresceva e la concorrenza globale ancora non mordeva.
Oggi, quel modello è crollato. Ma l’aspettativa è rimasta.
Risultato? Una generazione che credeva di dover “solo fare bene”, e si è ritrovata precaria, frustrata e col mutuo emotivo della colpa.
La fabbrica delle prestazioni: lavoro come performance, non come professione
Nel mondo contemporaneo, il lavoro si è smaterializzato:
non costruisci più scarpe, costruisci narrazioni.
Non sposti scatole, sposti dati, idee, emozioni.
E soprattutto: non sei pagato per quanto fai, ma per quanto vali nella percezione altrui.
- LinkedIn è il nuovo curriculum.
- Il personal branding è la nuova identità.
- La prestazione è la nuova fede.
Il lavoro non è più un mestiere. È una gara a ostacoli emozionali, una corsa a chi si vende meglio.
Sei sempre in vetrina. Anche quando sei a letto a scrollare offerte di lavoro su Indeed.
La modernità ha trasformato il lavoratore in prodotto, marketer di sé stesso, testimonianza ambulante della propria spendibilità.
Ma non preoccuparti: se ti rompi, ti chiamano resiliente.
👉 “Di questo meccanismo perverso abbiamo già parlato a fondo ne La grande truffa della produttività: lavorare meno e vivere meglio, dove smontiamo pezzo per pezzo l’equazione tossica tra ore lavorate e valore umano.”
La modernità ha trasformato il lavoratore in prodotto, marketer di sé stesso, testimonianza ambulante della propria spendibilità.
Il presente scomposto: tra identità liquide, passioni negate e lavoro come trauma sociale
L’identità in frantumi: quando il lavoro non ti contiene più
Nel mondo attuale, il lavoro non è più un perno stabile dell’identità.
È un costume di scena, che indossi finché ti regge addosso – poi via, prossimo ruolo.
Cambiano le aziende, cambiano le piattaforme, cambiano i contratti (quando ci sono). Ma soprattutto: cambi tu, continuamente.
Benvenuti nell’era della liquidità professionale:
ti chiedono di essere flessibile, formabile, entusiasta, ma anche competente, specializzato, disponibile h24.
Un ossimoro vivente. Una ginnastica dell’anima senza fisioterapista.
Il lavoro oggi ti chiede di essere tutto, ma non ti restituisce nulla di solido.
L’identità professionale diventa provvisoria, come l’ennesimo stage non retribuito.
E l’essere umano resta lì: appeso a un titolo, ma senza ruolo. Connesso, ma non riconosciuto.
Chi può scegliere (e chi non può nemmeno immaginare)
C’è chi può permettersi di seguire la passione, e chi no.
Chi ha tempo, contesto e capitale per esplorare il “lavoro dei sogni”, e chi sogna solo di arrivare a fine mese.
La retorica del “fai ciò che ami e non lavorerai un solo giorno” funziona solo se:
- hai un cuscino economico sotto,
- una rete sociale intorno,
- e non devi sostenere una famiglia con il tirocinio gratuito di marketing etico per startup spirituali.
La realtà è che lavorare per passione è un privilegio, non una regola.
Eppure, chi lavora “solo per soldi” viene spesso visto con sospetto morale: come se stesse tradendo un ideale superiore.
Ma quale ideale? Quello imposto da una società che valorizza la libertà solo se puoi permettertela?
Il vero squilibrio oggi è tra chi lavora per scelta e chi lavora per fame.
E la frattura non è solo economica, ma psicologica.
Uomo economico vs uomo sociale: una guerra civile interiore
Dentro ogni lavoratore si combatte una guerra.
Da una parte, l’uomo economico: orientato al guadagno, alla prestazione, all’efficienza.
Dall’altra, l’uomo sociale: che cerca riconoscimento, senso, connessione, utilità.
Lavorare per vivere, o vivere per contribuire? Guadagnare o appartenere?
Questa tensione genera distorsioni esistenziali:
- lavori tanto, guadagni bene, ma ti senti inutile.
- lavori in qualcosa che ami, ma non riesci a mantenerci una pianta grassa.
- fai un lavoro etico, ma sei emotivamente svuotato.
L’uomo economico ti spinge a performare.
L’uomo sociale ti chiede: ma lo stai facendo con qualcuno? Per qualcosa?
E mentre litigano, tu vai in burn-out.
In questo scenario, il lavoro non è più un mezzo per vivere: è un campo di battaglia.
Tra ciò che sei, ciò che vorresti essere, e ciò che ti è concesso fare.
I numeri del (dis)incanto
👉 Il 60% dei lavoratori europei dichiara di “non sentirsi coinvolto” dal proprio lavoro
📊 Fonte: Gallup – State of the Global Workplace 2023
Il coinvolgimento è ai minimi storici. La gente lavora, ma senza crederci, senza volerci stare, senza neanche sapere perché ci sta.
Un tempo si diceva “fare bene il proprio mestiere è una forma di dignità”.
Oggi è spesso una forma di sopravvivenza emotiva ben mascherata.
Fare il minimo sindacale è diventato un atto di difesa psichica.
Specialisti, generalisti e mutanti cognitivi: che forma ha il tuo cervello mentre lavori?
Lo specialista isolato: sapere profondo, campo ristretto, identità fragile
Nel Novecento il mantra era chiaro: diventa il migliore in qualcosa.
Scava, approfondisci, concentrati.
Diventa chirurgo della materia, maestro della competenza, guru di Excel.
E per un po’ ha funzionato: il sapere verticale era la chiave d’oro per aprire le porte del successo.
Più sapevi fare bene una cosa, più eri riconosciuto. E pagato.
Il mondo industriale adorava gli specialisti: erano prevedibili, misurabili, sostituibili.
Ma oggi, nel casino globale delle crisi interconnesse, quello stesso specialista rischia di diventare un recluso del proprio sapere.
Magari conosce tutto sul motore a combustione interna… proprio mentre le auto vanno a elettrico e il pianeta prende fuoco.
Lo specialista è come un neurochirurgo a bordo di una zattera: geniale, ma completamente inutile se l’acqua entra da tutte le parti.
La mente sistemica: il ritorno del generalista
In un mondo che cambia in tempo reale, sapere solo una cosa è come parlare una lingua morta in un rave.
Entra in scena il generalista, o meglio: il multidisciplinare.
Quello che:
- connette saperi,
- unisce punti lontani,
- ragiona per relazioni più che per compartimenti stagni.
Il mondo ha bisogno di queste menti orizzontali.
Figure ibride, traverse, capaci di essere ponte tra mondi.
Non per superficialità, ma per consapevolezza sistemica.
Certo, spesso vengono etichettati come “quelli che fanno un po’ di tutto”,
quindi pagati un po’ niente.
Ma sotto sotto, sono quelli che salveranno le organizzazioni… o almeno le aiuteranno a non impiccarsi con le proprie procedure.
Il lavoratore del futuro: radici profonde, rami che si intrecciano
Il futuro del lavoro non appartiene né allo specialista puro né al generalista disperso,
ma a chi riesce a radicarsi in una competenza,
e poi espandersi in più direzioni.
Un profilo nuovo: il traduttore tra mondi,
l’orchestratore di sistemi,
il mutante cognitivo.
- Che sa unire psicologia e design.
- Filosofia e programmazione.
- Sociologia e ingegneria.
- Scrittura e strategia.
Un lavoratore che non si definisce per settore, ma per modo di pensare.
Il vero valore non è solo cosa sai fare, ma quali conversazioni sei in grado di attivare tra saperi diversi.
In un mondo interconnesso, la capacità di connessione sarà la competenza più preziosa.
Il futuro (im)preparato: tra rivoluzione cognitiva e fallimento educativo
Il lavoro che viene: incerto, fluido, disumano o liberatorio?
Il lavoro del futuro non sarà un lavoro.
Sarà una sequenza di trasformazioni.
Una mappa mutevole, fatta di micro-competenze, di adattamento continuo, di flussi e interruzioni.
Non esisteranno più le carriere lineari.
Esisteranno percorsi obliqui, dove cambi mestiere, forma, identità, più volte nella vita.
E se ci pensi bene… sta già succedendo.
- L’intelligenza artificiale sta divorando interi comparti (e ne sta inventando altri).
- L’automazione sta riscrivendo il concetto stesso di “occupazione”.
- Le piattaforme stanno spostando il potere dai contratti agli algoritmi.
Il futuro del lavoro sarà una danza tra libertà e smarrimento.
E in questo scenario, il problema non è il cambiamento.
Il problema è che nessuno ci sta insegnando a danzare.
Il paradosso della passione
👉 Solo il 15% dei lavoratori italiani si dichiara coinvolto nel proprio lavoro
📊 Fonte: Business People – Italia, livello di engagement dei lavoratori fra i più bassi del mondo
Non si tratta di mancanza di impegno, ma di una diffusa disconnessione emotiva. Molti lavoratori si trovano in ruoli che non rispecchiano le loro aspirazioni o passioni, spesso per necessità economiche o mancanza di alternative.
La retorica del “segui la tua passione” si scontra con la realtà di un mercato del lavoro che offre poche opportunità di scelta.
La retorica della passione funziona solo se c’è qualcuno che paga le bollette mentre la insegui.
Una scuola pensata per il passato, con l’ansia del presente e zero visione del futuro
L’educazione oggi è la vera zona industriale del pensiero.
Formiamo studenti come se il mondo fosse ancora quello del 1983.
Orari rigidi, saperi incasellati, voti come gratificazione o punizione.
Insegniamo a ripetere, non a connettere.
A memorizzare, non a problematizzare.
A sopravvivere alle interrogazioni, non a pensare la complessità.
Nel frattempo, là fuori, il mondo chiede:
- Pensiero critico
- Empatia cognitiva
- Capacità di navigare l’ambiguità
- Adattamento etico, non solo tecnico
E la scuola cosa offre? Competenze settoriali, gerarchie autoreferenziali, programmi datati e zero contatto con il reale.
L’educazione sta mancando clamorosamente l’appuntamento con la trasformazione.
E nel farlo, sta tradendo il suo compito più alto: preparare a vivere, non solo a lavorare.
Educare al movimento, non alla funzione
L’analfabetismo funzionale e le lacune educative in Italia
👉 Il 43,5% degli studenti delle scuole superiori italiane non raggiunge i livelli minimi di competenza in italiano, e il 47,5% in matematica
📊 Fonte: Rapporto CENSIS 2024 – Umanesimo Digitale
Questi dati allarmanti indicano che quasi la metà degli studenti italiani non possiede le competenze di base necessarie per affrontare le sfide del mondo moderno. Il sistema educativo sembra incapace di fornire gli strumenti fondamentali per sviluppare un pensiero critico e analitico, lasciando molti giovani impreparati e vulnerabili in una società sempre più complessa.
Un sistema educativo che non coltiva il pensiero critico non forma cittadini liberi, ma individui facilmente manipolabili.
Serve una rivoluzione educativa, non solo riforme.
Una scuola che insegni a:
- Cambiare direzione senza perdere se stessi.
- Integrare saperi senza snaturarli.
- Fallire, riflettere, risalire.
- Lavorare insieme, non solo competere.
Serve un’educazione che non prepari al lavoro come status, ma al lavoro come parte di una vita piena.
Che alleni alla curiosità sistemica, alla responsabilità creativa, all’autonomia consapevole.
Perché il lavoratore di domani sarà un essere relazionale in un mondo instabile.
E non basterà saper fare.
Bisognerà saper stare.
CONCLUSIONE – Ripensare il lavoro come linguaggio dell’essere
Il lavoro non è il nemico. È un linguaggio.
Ma se continuiamo a usarlo per sottomettere, frenare, frustrare, non produrremo valore.
Produrremo sofferenza, vuoto, disillusione.
Forse il futuro non ci chiederà più che lavoro fai,
ma:
“In che modo ciò che fai ti mette in relazione con la vita?”
“Chi stai diventando, attraverso quello che fai?”
E sarà lì che capiremo se abbiamo fallito come civiltà.
O se finalmente abbiamo iniziato a lavorare con l’intelligenza della specie, e non con la paura del singolo.
🔎 Vuoi scoprire che maschera indossi ogni giorno?
Abbiamo parlato del lavoro. Ora tocca a te.
Se vuoi capire che ruolo stai interpretando nella farsa produttiva contemporanea, fai il test.
È ironico, psicologicamente spietato e un po’ troppo vero.
👉 Scopri chi sei davvero quando lavori
Se ti ha acceso qualcosa, non spegnerlo. Diffondilo.
Lascia un commento:
Se ti sei riconosciuto, indignato, ispirato o confuso – dillo. Qui sotto. Non ti giudica nessuno (per ora).
Condividi l’articolo:
Condividilo con chi lavora troppo, con chi finge di lavorare, o con chi si è appena licenziato perché sì. I pensieri fanno più rumore se viaggiano.
Iscriviti al Training di Sopravvivenza per Illuministi Bastardi:
Ogni settimana, una dose controllata di idee sovversive, test psicologici spiazzanti e strumenti per non impazzire (del tutto).
Non è solo una newsletter. È un piano di fuga.